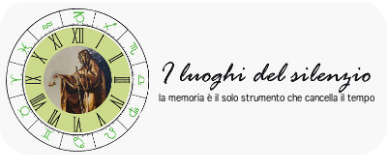Cenni Storici
La chiesa di Santa Maria di Sesto è la più antica tra le sette chiese di Civita dedicate alla Vergine. Eretta intorno all’XI secolo in stile romanico, sorge all’esterno della cinta urbica medioevale, nei pressi dell’attuale stazione ferroviaria.
La struttura è stata eretta su un preesistente luogo di culto pagano, probabilmente dedicato a Vacuna, dea madre pre-romana della fertilità, della salus e dell’acqua molto venerata in tutto il bacino della Alta Valle del Velino e in Sabina, cui era dedicato il santuario pan sabino di Aquae Cutiliae, localizzato ad appena cinque km dalla chiesetta.
L’antichità dell’uso religioso della zona è confermata anche dalla sua vicinanza al percorso della Salaria.
La chiesetta, sorta circa trecento anni prima della costituzione del centro urbano di Cittaducale, è già documentata nell’anno 967 come pertinenza dell’Abbazia di Farfa.
Servì come monastero femminile intorno al X secolo; nel XV secolo fu sotto il patronato di Margherita di Buccio di Bertoldo, di Maria di Buccio di Bertoldo e, in seguito, di Don Mattione di Cantalice.
Il centro religioso risultò particolarmente vitale almeno fino alla metà del XV secolo, quando funzionò come sede di catechismo, con una rendita di 3 fiorini.
La chiesetta è menzionata più volte anche negli Statuta Civitas Ducalis del 1466, ove è ricordata come beneficiaria delle elemosine da versare obbligatoriamente a favore delle istituzioni religiose locali, insieme con la Chiesa di Santa Croce, di San Giovanni, di Sant’Antimo e di Sant’Agostino.
In seguito agli eventi sismici del 1502 e a causa anche del maggiore sviluppo della cattedrale di Santa Maria del Popolo, locata nella Piazza del Popolo del nuovo borgo cittadino, la chiesa di San Sesto fu pressoché abbandonata nel corso del XVI secolo.
Per volontà del Vescovo di Cittaducale Mons. P. Paolo Quintavalle fu predisposta la sua ristrutturazione.
Nella prima decade del secolo XVII la chiesa è stata ampliata con prolungamento della navata, che si è estesa fino a inglobare il preesistente pronao, provvista di nuovi portali (1608) e di una nuova facciata, ispirata alle correnti sensibilità barocche e terminata nel 1613.
Anche per gli interni fu previsto un intervento di recupero, realizzato con un nuovo ciclo decorativo barocco dell’abside.
Al termine dei lavori, nel 1620, fu incastonata sul pavimento un’epigrafe commemorativa incisa su undici righe in caratteri ispirati alla scrittura capitale quadrata di classica ascendenza, riportante: P. PAUL. QUINT./EP.US C. DUCALIS/ BASILICAM S. MARIAE/ DE SEXTO IN UMBILICO/ITALIAE XL DIERUM/INDULG. STAT. /VISIT. DOM. AC FESTIS/ A.D. MDCXX.
La vitalità del centro religioso venne, tuttavia, a ridursi con il passare del tempo.
Si ha notizia (1688) che ivi si officiasse solo in occasione del 15 agosto mentre non erano presenziate le altre funzioni a causa della dislocazione rurale della struttura.
La chiesa di Santa Maria di Sesto fu al centro del dibattito per la costruzione della tratta ferroviaria che collegava L’Aquila-Rieti-Terni che la vide inglobata nel circuito primario di transito. Rimase comunque particolarmente cara alla devozione spirituale dei civitesi che, almeno fino al secondo dopoguerra (1945) erano soliti recarvisi per osannare la Madonna nel giorno dell’Assunzione.
È nota anche per essere la chiesa ove insiste il vero centro geografico d’Italia, conteso con la vicina Rieti.
Nonostante oggi appaia piuttosto spoglia, la chiesa era anticamente decorata a mosaico con tessere in pietra e di particolare pregio dovevano essere gli interni, impreziositi da cicli di affreschi databili intorno al XIII e XIV secolo.
Aspetto esterno
Addossati alla chiesa si notano i resti degli antichi edifici conventuali e la sagrestia seicentesca.
La facciata, oggi spoglia, è classicamente definita da due coppie di paraste tuscaniche, a sorreggere un timpano triangolare: è praticamente sospesa sopra il tracciato ferroviario; il portale seicentesco è anch’esso sormontato da timpano e privo di ornamenti.
L’abside è di tipo romanico con pianta semicircolare, è costruita con blocchi di grandi dimensioni ben connessi tra di loro, si nota la presenza di una finestra, ora tamponata.
La muratura delle pareti esterne è anch’essa realizzata con blocchi di rilevanti dimensioni nella parte più antica, mentre diviene irregolare nella zona prossima alla facciata, frutto del rifacimento seicentesco.
Sulla parete sinistra si apre un ingresso secondario, nei pressi del quale si notano resti di murature romane.
Il campanile a vela a un solo fornice è posto posteriormente, in linea con la parete destra della chiesa.
Interno
L’interno è a navata unica con copertura a capriate lignee, termina con un’abside a pianta semicircolare, il presbiterio è rialzato di un gradino.
Lungo la parete sinistra, nell’area presbiteriale, si trova affrescata una Madonna col Bambino dall’aspetto seicentesco, la Vergine è racchiusa in una cornice di nuvole, la testa coronata è circondata da un’aureola stellata, rispondente alla tipologia iconica di Maria Hodighitria; rappresentata in posa astante, ella tiene in braccio il bambino in atto benedicente.
Ai suoi piedi, come d’uso di piccole dimensioni, i tre donatori genuflessi.
Il primo uomo è vestito di un saio francescano e porta tra le mani un rosario, la seconda figura, femminile rivolge lo sguardo alla Madonna e con un gesto della mano sinistra indica la Vergine; il terzo personaggio in posa orante, un laico veste secondo la moda del tempo sorregge anch’egli un rosario in mano.
Segue un’Annunciazione, di cui rimane solo la Vergine, il distacco di intonaco nella zona ove era l’Angelo annunziante ha fatto riemergere un lacerto di affresco di età più antica.
Sull’arco trionfale, a sinistra, è affrescata una Crocifissione, dall’aspetto ancora trecentesco, ai lati del Cristo la Madonna e, probabilmente, San Giovanni, di cui rimane solo la parte inferiore.
La decorazione dell’abside risale probabilmente ai primi decenni del XVII secolo, quando la chiesa fu restaurata a opera del vescovo Pietro Paolo Quintavalle.
Nella calotta absidale è affrescata la Madonna assunta contornata da una cortina di nuvole sorretta da putti e angeli, sopra di Lei allarga le braccia per accoglierla Dio Padre, emergente da una nuvola.
L’arco è decorato con grottesche.
Sul tamburo, a sinistra, un distacco di intonaco ha fatto riemergere la figura di San Sebastiano, pertinente alla preesistente.
Al di sotto si nota la presenza di un frammento più antico raffigurante la testa di un santo con aureola, verosimilmente da indentificare con il Battista.
I tre strati di affreschi testimoniano il cambiamento di gusto e le vicissitudini della chiesa interamente ristrutturata nei primi decenni del XVII secolo per volere del vescovo di Cittaducale Pietro Paolo Quintavalle (1609-1627).
Il primo, riferibile al Battista e al frammento che le fa da pendant all’estrema destra dell’abside raffigurante la testa di una Santa con corona e aureola, presenta dal punto di vista stilistico e compositivo quei caratteri pienamente riferibile a un ambiente giottesco molto diffusi nella pittura laziale del XIV secolo.
Il secondo, quello del San Sebastiano collocato al centro di una nicchia con colonnine e drappo a motivi eseguiti a stampino, è saldamente informato di una tradizione tardogotica diffusa tra Umbria e Lazio alla fine del Quattrocento e ai primi decenni del Cinquecento.
Infine, il terzo, di cui restano solo le grottesche di non elevata qualità, ascrivibile al tempo dei lavori di rifacimento promossi dal Quintavalle.
La superficie dell’emiciclo è scandita da paraste dipinte a finto marmo entro le cui specchiature sono inseriti motivi ornamentali a candelabre vegetali e floreali, con capitelli che sorreggono idealmente una cornice architettonica modanata.
All’interno dei riquadri, contro un sfondo paesaggistico, la decorazione è completata da un’alta fascia policroma a strisce oblique che giunge fino a terra.
Partendo da sinistra si scorge San Pietro con le solite chiavi, poi la Madonna coronata col Bambino, ambedue sorreggono un globo, alle loro spalle San Gregorio papa che indica il globo sostenuto dalla mano destra del Bambino e la sua colomba.
Chiude il tamburo San Paolo con la spada.
Sulla grottesca posta all’estrema destra dell’abside, una caduta di intonaco ha fatto emergere la testa di una Santa con aureola e corona, presenta dal punto di vista stilistico e compositivo le stesse caratteristiche del san Giovanni cui fa da pandant.
L’altare, molto simile ad altri esemplari presenti nelle chiese del reatino, probabilmente risale alla ristrutturazione dei primi decenni del XVII secolo, la fronte si presenta oggi completamente ridipinta
Sulla parete destra si trova, molto danneggiata, una rara rappresentazione della Dormitio Virginis, che mostra caratteri stilistici tardo quattrocenteschi.
In una teca sono conservati alcuni frammenti di pavimentazione musiva.
Lungo le pareti della navata, al di sotto di strati sovrapposti di intonaci e ridipinture si notano resti della decorazione forse ancora trecentesca, sono visibili una Madonna in trono col Bambino che sorregge un cartiglio con scritte gotiche e un Sant’Onofrio, ove si notano interessanti graffiti devozionali; ai suoi piedi la committente orante.
Tutti gli affreschi meriterebbero una specifica campagna di restauro e di valorizzazione.
Fonti documentative
https://www.academia.edu/42258411/Basilica_di_Santa_Maria_di_Sesto_in_Cittaducale
https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1201221964
Nota
La galleria fotografica ed il testo sono stati realizzati da Silvio Sorcini.
Da vedere nella zona
Antiche Terme di Vespasiano e Chiesa di Santa Maria di Cesoni
Chiesa di Santa Maria in Vittorino
Mappa
Link alle coordinate: 42.38846674331433, 12.942158559362733