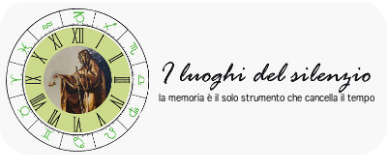Cenni Storici
È stata costruita ai margini delle mura castellane tra il 1093, data del primo documento in cui compare il Fondo di Fabrica, e il 1177, data in cui una bolla di Alessandro III conferma l’esistenza del Duomo. In quel periodo è proprietà del monastero di Sant’Elia.
Tra la fine del XIII e l’inizio del XV secolo la Chiesa si trovava in stato di abbandono, coperta da una folta vegetazione.
Nella seconda metà del XV secolo la Chiesa fu ampliata e riaperta per l’esercizio del culto. L’intervento fu voluto da Alessandro VI Borgia; in quell’occasione essa fu proclamata Chiesa Parrocchiale di Fabrica.
Nel 1655 iniziarono i lavori di restauro della pavimentazione interna, che terminarono nel 1657.
Nel 1661 una delle campane della torre subì un grave danno e fu sostituita.
Nel 1672 fu inaugurato il nuovo campanile ricostruito da mastro Darri di Canepina su disegno di Sigismondo Iannone, a base quadrata in blocchi di pietra locale.
Nel 1772 furono eseguiti lavori di ristrutturazione interna che comportarono la trasformazione dello spazio interno in un nuovo ambiente neo-classico, ricco di modanature, lesene, capitelli, fregi decorativi e stucchi preziosi; i lavori terminarono nel 1775.
Nel 1955 la decorazione a grottesche e le piccole scene di argomento pastorale e biblico, poste lungo il sottarco absidale e sulle paraste, furono restaurate ad opera di maestranze locali.
Nel 1990 fu realizzato un nuovo ambone in marmo in sostituzione del precedente in legno.
Aspetto esterno
La facciata si presenta semplice e austera, con terminazione a timpano.
L’ingresso principale è in asse con l’oculo sovrastante, rifiniti entrambi con fasce in peperino.
La struttura portante è costituita da murature in tufo locale e da volte in conglomerato cementizio a base pozzolanica; la copertura è composta da capriate in legno di castagno, travature di sostegno, pianelle in cotto, tegole e coppi alla romana.
Il campanile si trova sul lato destro, l’architettura è riconducibile alla scuola romana, è stato realizzato utilizzato: pietra invece dei più comuni laterizi.
Presenta marcate linee orizzontali che delimitano i vari piani in cui si aprono finestre bifore e monofore; è addossato alla facciata principale della chiesa, di base quadrata e coronato da cuspide conica.
Le fondazioni sono del tipo a sacco in muratura di tufo e pietra locale.
Interno
L’interno ha mantenuto la forma originaria a un’unica navata con volta a botte, terminante con abside a pianta semicircolare.
L’interno è piuttosto ricco nella caratterizzazione delle pareti longitudinali, rivisitate in chiave neo-classica, e presenta lesene doricheggianti a sostegno di arcate a tutto sesto che sormontano le cappelle laterali; al di sopra corre un finto architrave ricco di modanature.
All’interno delle nicchie vi sono altari dedicati a vari santi.
La pavimentazione è costituita da lastre in marmo bianco di Carrara.
Nel primo altare di sinistra la pala raffigura un’Annunciazione.
Nella pala del secondo altare di sinistra la Madonna, con in braccio il Bambino, offre un giglio a Santa Caterina d’Alessandria.
Segue un pulpito ligneo.
Nel terzo altare di sinistra la pala raffigura la Madonna in gloria tra santi.
Nella grande nicchia di sinistra rimangono i resti di un grande affresco raffigurante la Madonna del Rosario con San Domenico e devoti.
L’opera è assegnabile, in base a valutazione stilistica a Lorenzo Torresani.
Al registro inferiore è raffigurato San Domenico e devoti, a sinistra gli uomini, tra cui si notano un re, un papa e un vescovo, a destra le donne, tra cui una Santa monaca.
Sopra è affrescata la Madonna del Rosario.
Rimane un unico superstite dei quindici tondi che circondavano l’affresco della Madonna del Rosario, raffiguranti i Misteri del Rosario.
Le altre scene della calotta non sono intellegibili.
Nel catino absidale è rappresentata la Gloria del Redentore.
Per il Redentore come anche nelle tipologie dei personaggi sacri presentì nella scena, sono stati utilizzati gli stessi cartoni impiegati nel Giudizio Universale reatino.
L’opera è assegnabile, in base a valutazione stilistica a Lorenzo Torresani, probabilmente in collaborazione col fratello Bartolomeo, o quantomeno riutilizzando parte dei suoi cartoni.
Il Salvatore benedicente è inserito in un nimbo dorato circondato da testine di putti, ai cui lati quattro angeli mostrano i simboli della Passione chiodi, croce, colonna e corona di spine.
Allineati su un livello più basso sono presenti vari Santi e personaggi biblici, partendo da sinistra si riconoscono: Adamo; Abele; Eva; la Madonna dal volto rovinato: San Giovanni battista; Noè con l’arca, Abramo che impugna il coltello per sacrificare il figlioletto Isacco.
Sotto, una teoria di Santi apostoli e profeti, si riconoscono tra gli altri: San Bartolomeo col coltello in mano veste bianca e libro; San Giovanni col calice; San Pietro con la chiave; Aronne con veste sacerdotale, tiara e verga; dietro fa capolino Gedeone con l’elmo, poi Mosè con le tavole della legge; Re David con corona e cetra; San Paolo di Tarso con libro e spada; Sant’Andrea con la croce decussata, San Matteo con penna, libro e angelo; San Tommaso, San Giacomo maggiore; dietro San Girolamo col galero rosso cardinalizio; due papi barbuti, forse San Silvestro e San Gregorio magno, e un Santo, anch’egli barbuto, non riconosciuto.
Il Mosè non è una copia di quello michelangiolesco come nell’opera reatina, ma una libera creazione che ricorda il Sant’Antonio abate del Giudizio di Rieti.
Relegati in seconda fila occhieggiano altri personaggi con le aureole, i quali risultano difficilmente riconoscibili vista la mancanza di attributi.
Chiudono l’affresco quattro piccoli angeli musicanti.
Sullo sfondo è affrescato un cielo stellato.
In questa Gloria, di composizione solenne e scenografica, vi è una citazione abbastanza evidente della Disputa del Sacramento di Raffaello.
Nel tamburo, a sinistra, è affrescata l’Ultima cena: la scena si svolge in una grande aula rettangolare chiusa da un soffitto a cassettoni decorato da rosette.
Nella parete che fa da sfondo alla scena, si apre un grande arco a tutto sesto attraverso il quale si scorgono degli edifici, un portico, una cupola; l’arco è fiancheggiato da lesene ornate da candelabre, ai cui lati si trovano due scene che mostrano Mosè che riceve le tavole della Legge e Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia.
Al centro del tamburo la Crocifissione riprende uno schema già utilizzato in una delle scenette dell’abside destra della chiesa di Santa Maria Assunta in Arrone.
Attorno al Cristo svolazzano due angeli che raccolgono il sangue delle sue ferite, ai lati armigeri e personaggi a cavallo, uno probabilmente è Giuseppe d’Arimatea.
Al registro inferiore San Silvestro papa, un armigero, santa Maria di Cleofa, la Madonna, Santa Maria Maddalena abbracciata alla croce ai piedi di Cristo, San Giovanni, Santa Salomè, e San Lorenzo con la graticola.
Fa da sfondo alla scena un paesaggio collinare ricco di particolari, speroni di roccia, edifici, piccole vedute di paesi.
Nella Flagellazione la scena si svolge su un fondale architettonico classicheggiante, un portico con volte a crociera su pilastri in pietra grigia.
Gli affreschi del tamburo sono opera di Lorenzo Torresani, forse con l’ausilio del fratello Bartolomeo e riportano la data d’esecuzione: 1556.
Nel sottarco, sempre opera dei Torresani, si alternano Profeti, quadretti con paesaggi e grottesche.
Sotto l’altare centrale è custodito il corpo coperto di cera di San Giustino Martire, patrono insieme a San Matteo, della cittadina di Fabrica di Roma, le cui spoglie arrivarono da Roma il 22 settembre 1791, donate da Pio VI e contiene ancora oggi il corpo del Santo.
Ogni cinque anni, lo stesso giorno del primo trasporto, l’urna è portata in processione.
Nei giorni dei festeggiamenti si svolge la Corsa dei carrettini artigianali.
I partecipanti scendono in velocità la Circonvallazione dalla chiesa fino a via Roma.
Nel terzo altare di destra è collocata una moderna statua di Santa Rosa da Viterbo, segue il secondo altare con una pala raffigurante le anime purganti e l’Assunta, quindi il primo altare di destra, ove la pala raffigura la Madonna col bambino e in basso San Francesco d’Assisi e Santa Rosa da Viterbo.
Fonti documentative
https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/86435/Chiesa+di+San+Silvestro+Papa
Nota
La galleria fotografica ed il testo sono stati realizzati da Silvio Sorcini.
Mappa
Link alle coordinate: 42.334674695588475, 12.295527791837904